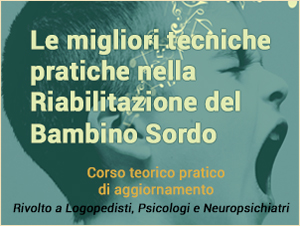In una camera di ospedale, un paziente cieco può muoversi con sufficiente disinvoltura, sempre che vengano rispettate le più elementari norme dell’ordine e dell’igiene.
Generalmente il suo arrivo e la sua presenza vengono accolti dagli altri pazienti e dal personale in servizio con sincera benevolenza e con quel pizzico di commozione che rende più difficili le domande pratiche e molto più facili le considerazioni e le espressioni mistiche e morali.
Naturalmente anche in ospedale la persona non vedente viene giudicata meno capace di quanto non sia in realtà. Si ritiene infatti che, a prescindere dalle sue condizioni di salute, preferisca mangiare a letto, essere accompagnato al bagno, essere aiutato a muoversi in qualunque circostanza.
D’alta parte si cerca la sua attenzione mediante comportamenti visivi, ma in compenso ci si scusa con lui per aver usato parole visive come “vedi, guarda, rosso” e così via.
Fin qui nulla di particolare. Le reali difficoltà sopraggiungono quando il paziente che non vede chiede che le abitudini quotidiane dell’ospedale vengano in qualche misura adattate alle sue particolari esigenze: cambiare posto al cestino dei rifiuti, descrivere il contenuto delle scatole che compongono il pranzo precotto, offrire un’assistenza più assidua durante le terapie-flebo, anticipare con le parole qualunque manipolazione corporea, facilitare il passaggio pedonale lungo il corridoio del reparto e tante altre accortezze di questo genere.
La forza delle abitudini induce il personale in servizio a preferire la presenza di un parente o di un amico del paziente cieco, affinché integri le sue funzioni sensoriali e consenta così la continuità della solita routine.
Desidero sottolineare che simili considerazioni non intendono amplificare la dimensione dei problemi pratici, che in ogni caso risultano affrontabili e risolvibili, soltanto con qualche fatica in più.
Vogliamo piuttosto riferirci all’esperienza interiore del paziente cieco,
che già è costretto a pazientare a causa delle sue condizioni di salute e deve inoltre esercitare la sua pazienza poiché ancora una volta si trova incluso in un contesto che non dimostra l’intenzione di conoscerlo, ma soltanto emozioni e fantasie compassionevoli nei suoi confronti.
Per fortuna si presentano anche alcune eccezioni, vale a dire persone che dimostrano di voler capire e che sollevano sensibilmente il nostro spirito, rafforzando la convinzione che i nostri problemi sono comunque comprensibili da una convivenza sociale un po’ più attenta e un po’ più caratterizzata dal desiderio di conoscere.
Qualcuno potrebbe osservare che in fondo l’ambiente dell’ospedale non rappresenta che uno dei tanti ambienti di una società che offre nel suo complesso le caratteristiche descritte in precedenza. E che pertanto una persona non vedente dovrebbe immaginare, al momento del ricovero, quella che sarà presumibilmente la sua esperienza ospedaliera.
A questo proposito vorrei dire semplicemente che la condizione di malattia, soprattutto quando presenta segnali preoccupanti, rafforza oltremodo il nostro bisogno di essere accolti, riconosciuti, compresi e confermati nella nostra condizione personale.
In tal senso ritengo sia lecito esigere che un contesto sanitario presenti, almeno in misura osservabile, la disposizione a capire e a ragionare circa le differenze individuali.