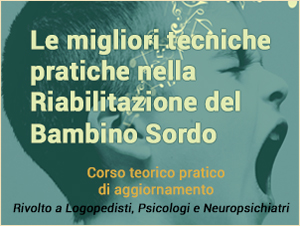Dalle nostre parti una volta i figli venivano messi al mondo per accrescere la forza vitale della famiglia ed anche la sua capacità di produrre.
In un certo senso essi venivano accolti e riconosciuti in una prospettiva di utilità e naturalmente, secondo questa logica, i più sani e i più forti venivano accolti con maggiore gradimento.
Nello spazio di vita della famiglia c’era posto comunque per tutti, sani e malati, forti e deboli, belli e brutti, capaci ed incapaci, erano tutti presenti nella cosiddetta area della convivialità, dove si svolgeva una parte considerevole della vita quotidiana, in un contesto di esseri umani, di animali e piante.
Giova comunque ribadire che in ogni caso i più sani e i più forti rappresentavano la parte valida della famiglia, quella che di fatto contava nell’ambito della vita sociale.
Evidentemente oggi le condizioni sono mutate e questo è vero in particolar modo nella realtà sociale del benessere, vale a dire nelle famiglie ispirate dalla cultura dell’abbondanza.
In simili famiglie i figli vengono messi al mondo per essere felici e per confermare in questo modo la buona riuscita della famiglia.
Considerato con superficialità, questo fatto appare un bel segno del progresso, un traguardo confortante lungo il cammino della nostra civiltà.
Viceversa se lo esaminiamo con maggiore attenzione, esso presenta la sua natura insidiosa e la sua struttura paradossale.
Infatti la conquista della felicità, nella più semplice delle ipotesi, ci sembra un’operazione piuttosto complessa e più che altro l’esito propizio proveniente dalla conquista di un altro obiettivo.
Ad esempio, possiamo essere felici per un successo sportivo, per un’impresa avventurosa, per un’esperienza sentimentale, per un buon risultato scolastico e così via.
Pertanto nel momento in cui è la felicità che diviene l’obiettivo da raggiungere, essa tende a coincidere e a confondersi con il piacere immediato e con le pratiche del consumo di merci desiderate.
In altre parole non si può essere felici per aver gustato un ottimo gelato, poiché il ricordo di un simile piacere si trasforma troppo rapidamente in un nuovo desiderio.
D’ altra parte neppure una lunga sequenza di simili piaceri può comporre efficacemente un quadro di felicità, perché la moltiplicazione dei piaceri immediati intensifica proporzionalmente anche la paura della privazione delle merci desiderate.
Dobbiamo inoltre aggiungere che fare un figlio affinché sia felice rappresenta un vero e proprio paradosso.
Anche se involontariamente, in questo modo infatti la felicità diviene una prescrizione, una sorta di dovere da realizzare, il compito della propria esistenza.
Francamente chiedere a un figlio di essere felice genera un insieme di contraddizioni faticose da vivere e difficili da sbrogliare.
In definitiva converrebbe riprendere in mano gli antichi obiettivi dell’educazione, vale a dire quelli che comprendono anche l’impegno e la capacità di rendersi utili.
In questi obiettivi la fatica è un ingrediente esplicito e misurabile, quindi più facile da immaginare e da governare.
Essere felici per aver faticato con profitto è impegnativo, ma rappresenta pur sempre una solida prospettiva per la nostra esistenza.
Essere infelici per un piacere immediato che, nonostante l’aumento della frequenza e della intensità, non offre la prospettiva della continuità e della durata, rappresenta un insieme di frammenti di luce che mettono in evidenza, con la loro luminosità, il vortice oscuro della privazione.
In una prospettiva di impegno, il piacere di un buon gelato, di una corsa in moto, di una magnifica serata o qualcos’altro di simile, costituisce un modo per festeggiare uno stato di felicità e non l’illusorio strumento per procurarsela.