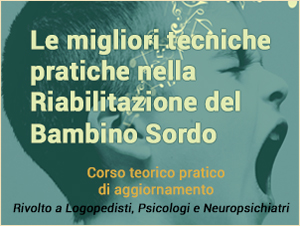Quel giorno del 1961 uscimmo con molto anticipo dalle classi per cercare in giardino una buona postazione da dove osservare, forniti delle più moderne attrezzature, questo interessante fenomeno naturale che si sarebbe manifestato, così dicevano gli studiosi, con insolita e drammatica evidenza.
Gli studenti erano piuttosto eccitati dall’attesa e gareggiavano nel mostrare le potenzialità tecniche delle loro macchine fotografiche, dei loro cannocchiali e dei filtri per guardare meglio proteggendo gli occhi.
Logicamente io non avevo portato nulla con me, se vogliamo escludere un semplice filtro protettore della retina che mi era stato consegnato dalla direzione della scuola.
Non si può dire che vivessi con estraneità quella situazione, ma certamente ero molto meno interessato degli altri, molto meno incuriosito da ciò che avrei visto e del resto non sapevo neanche bene cosa avrei potuto vedere.
Arrivò il momento dell’eclissi e devo dire che provai una forte emozione nel constatare questo improvviso e intenso oscuramento del cielo. Non si trattava soltanto di qualcosa da vedere con gli occhi. Ad esempio il suono degli uccelli che cercavano riparo tra gli alberi delle ville d’intorno, mostrava un batter d’ali eccessivamente rapido, quasi disperato.
D’altra parte il quasi totale oscuramento del sole aveva prodotto in pochi minuti un brusco e imprevisto abbassamento della temperatura, tanto da provocare brividi di freddo ed una vaga sensazione di smarrimento.
Tutto questo mi procurava entusiasmo e mi faceva essere contento di partecipare con i miei compagni di scuola ad un’esperienza che chissà quando avremmo avuto l’occasione di rivivere.
Tornata la normalità, i miei compagni parlarono molto delle loro osservazioni e dissero cose che se analizzate con attenzione mi avrebbero fatto comprendere l’incomparabile acutezza della loro funzione visiva e per contrasto la gravità del mio limite.
Viceversa accadde che il piacere della partecipazione all’evento, rafforzò in me il desiderio di annullare la sensazione del limite visivo e di concentrarmi su ciò che avevo vissuto in comune con gli altri.
Ero soddisfatto ma nel tornare a casa con alcuni miei amici sentivo la necessità di cambiare l’argomento della conversazione e cercai di parlare con una mia amica della festa da ballo del prossimo sabato sera.
Qualche giorno più tardi avvenne qualcosa di ben più importante, che mi fece cambiare non poco il mio atteggiamento nel confronto con il limite sensoriale.
Un ragazzo portò a scuola per primo le immagini fotografiche dell’eclissi di sole. Io le presi in mano e dovetti constatare contro ogni mio desiderio che vi si vedeva in forma chiara e molto ben delineata la luna che si sovrapponeva al sole, lasciandone libera soltanto una piccola porzione.
Si potevano vedere anche le disomogeneità della luna e gli effetti cromatici d’intorno dell’intero eclissi.
Uno spettacolo davvero emozionante, capace di offrire concretezza al nostro rapporto con l’universo e di conferire all’astronomia un valore estetico oltre che scientifico.
Il pensiero che un occhio normale potesse vedere tutto questo rappresentò un vero ciclone nella mia mente. Pensavo alle stelle, agli altri fenomeni naturali, ai paesaggi, agli orizzonti urbanistici e per la prima volta mi sentivo nell’angustia di un limite che mi separava molto dalle grandi realtà del mondo circostante.
Da quel giorno mi occupai molto di più di osservare le fotografie che ritraevano oggetti lontani, soprattutto di aerei e di uccelli d’alto volo.
Avevo sempre ridotto banalmente questi oggetti lontani a minuscoli punti oscuri, accompagnati nel caso degli aerei da un grande frastuono.
Numerosi viaggi in mare mi spinsero ad acquistare un cannocchiale da marina, devo dire con qualche soddisfazione. Dovetti rendermi conto molto presto che l’uso del cannocchiale mi provocava violenti dolori alla testa che naturalmente, oltre al disagio fisico, non costituivano certo un trattamento benefico per la salute dei miei occhi.
Il giorno dell’eclissi di sole ha rappresentato per la mia vita un giorno di crescita della mia curiosità ed anche una dolorosissima presa di coscienza del mio limite visivo.
Spesso nella vita la curiosità e il dolore del limite si intrecciano indissolubilmente. Per crescere compiutamente occorre senz’altro viverli entrambi.
Spesso le istituzioni scolastiche, soprattutto con gli alunni ipovedenti, tendono più che altro a mimetizzare il limite presente.
In questo modo eludono il confronto con la disabilità senza sostenere e promuovere i motivi della curiosità.
Possiamo dire che così facendo l’istituzione scolastica rinuncia al suo mandato istituzionale per naufragare in una scuola di trasmissione delle abitudini.
Per non far soffrire il soggetto ipovedente, lo si lascia nel suo far finta di essere normale, sperando che il futuro riservi alla sua vita meno amarezza possibili.
Pensate se io fossi stato educato dalla scuola ad utilizzare il mio residuo di funzione visiva. E’ vero che avrei conosciuto prima il dolore del confronto con i miei limiti ma è altrettanto vero che questi miei limiti si sarebbero ridotti e soprattutto si sarebbe potenziata la mia disposizione ad apprendere e la mia capacità di utilizzare strumenti di apprendimento.
Molti ragazzi ipovedenti vogliono andare in motorino, trasgredendo spesso le regole delle loro famiglie e vivendo consistendo pericoli per se stessi e per gli altri.
Quando parliamo di educazione stradale, ci dovremmo riferire con particolare attenzione alla condizione del ragazzo ipovedente perché in lui il desiderio, quando non viene moderato dalla consapevolezza, assume carattere esplosivo e incontrollabile.
Giova sottolineare che per fare tutto questo non sono necessarie molte energie sia economiche, sia mentali. Si tratta molto semplicemente di comprendere il valore di questo discorso e di trovare in classe una forma di comune coinvolgimento, un gusto di apprendere insieme anche i limiti del ragazzo non vedente, in modo da offrire una concreta e significativa esperienza di integrazione scolastica.