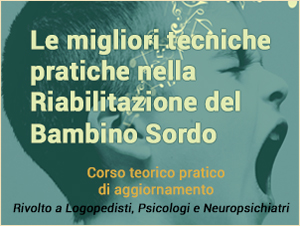L’educazione del bambino cieco può divenire per l’educatore un interessante percorso di apprendimento e talvolta può modificare le dimensioni della sua professione, offrendo nuovi segnali al senso della sua stessa vita.
La prima volta che vidi un ragazzo cieco di quattro anni prendere la rincorsa per poi saltare, con sufficiente disinvoltura, cinque panche avvicinate in parallelo, pensai che il sesto senso dei ciechi fosse davvero una realtà.
Avevo avuto l’occasione di osservare la tecnica e le modalità con cui il bambino prendeva distanza dall’ostacolo, misurando con grande accortezza i passi all’indietro, per poi scattare in avanti all’improvviso, ripercorrendo gli stessi passi identici per numero e lunghezza nella direzione dell’ostacolo.
Avevo osservato con attenzione il momento entusiasmante dello stacco da terra, lo slancio dinamico e ben governato al di là delle panche. Avevo vissuto il sollievo dell’atterraggio morbido e leggero.
I miei occhi avevano percepito con certezza tutto questo, e pure persisteva nella mia mente qualcosa di inspiegabile e di incredibile, che mi spingeva a pensare questa sorprendente esperienza mediante spiegazioni magiche che richiamavano strumenti extrasensoriali.
L’aspetto più sconcertante era pensare che il bambino potesse fidarsi di una realtà presente nella sua immaginazione ma non di fronte ai suoi occhi.
Sembrava che il bambino si lanciasse nel vuoto, confidando esclusivamente nelle misurazioni di allontanamento e di avvicinamento all’ostacolo.
Veniva a mancare nella sua esperienza quel contatto, quel controllo dell’ambiente circostante che ci consente di slanciarci in avanti con sufficiente sicurezza.
Per me diveniva necessario immaginare un suo modo di essere in contatto con il mondo d’intorno, una specie di occhio magico interno, con il quale il bambino percepisse la realtà dell’ambiente e trovasse il coraggio di saltare.
Quello che avrei capito conoscendo meglio le possibilità presenti nella condizione di cecità, riguarda soprattutto l’interezza del suo percepire e la forza possibile della sua immaginazione.
Forse gli speleologi, costretti in alcuni casi ad usare misurazioni e deduzioni logiche per decidere la praticabilità di un cunicolo cieco, non farebbero fatica a comprendere la situazione percettiva del bambino non vedente nell’atto di saltare le panche.
Occorre comunque precisare che la condizione di cecità, se confrontata con l’assenza della luminosità ambientale, presenta una più solida interezza percettiva, in quanto l’impossibilità di vedere viene in essa avvertita come più naturale e meno incombente.
Nel suo essere cieco, il bambino vive con naturalezza la sua condizione percettiva, utilizzando gli strumenti sensoriali e immaginativi di cui dispone.
Sono i sensi residui che offrono le dimensioni del suo rapporto con l’ambiente, logicamente integrati e potenziati dalla vita immaginativa.
E’ proprio l’immaginazione che ci consente di oltrepassare l’orizzonte del nostro campo percettivo e di guardare ben al di là del nostro patrimonio sensoriale.
La concezione del possibile poggia interamente sulla forza dell’immaginazione e sulla convinzione che tale forza potrà consentirci di conoscere un mondo più ampio e di costruire una realtà migliore.
Quando il campo percettivo risulta più esteso del volume esplorabile con le mani, il patrimonio sensoriale del soggetto non vedente si dimostra piuttosto confuso, soprattutto per quanto concerne un rapido ed efficace orientamento.
Occorre che il bambino cieco impari ad integrare ricordi, percezioni e deduzioni rappresentative affinché i suoi limitati strumenti sensoriali divengano significativi e affidabili.
In altre parole nel caso del bambino cieco il passato, il presente e il futuro costituiscono un continuum interattivo e vissuti della coscienza molto più elaborati.
Potremmo dire che da una condizione di limite scaturisce per necessità uno sviluppo epistemico molto più qualificato.
Naturalmente ciò avviene solo quando questa necessità è riconosciuta dall’educatore ed è conseguentemente assunta come riferimento metodologico fondamentale.
Viceversa educare il soggetto disabile visivo come un soggetto vedente, in attesa di recuperare la perduta normalità sensoriale, non potrà che produrre un esito disastroso.
Se riuscissimo a comprendere il valore delle possibilità presenti in un’esperienza conoscitiva più coinvolgente l’intero soggetto che conosce e più elaborata dalla sua coscienza, saremmo indotti ad estendere la metodologia didattica utilizzata per i ciechi anche per gli altri bambini.
Questo avverrà soprattutto quando impareremo a guardare con maggiore fiducia oltre i confini del nostro orizzonte sensoriale, offrendo maggiore forza alla concezione del possibile e maggiore vivacità alla nostra immaginazione.