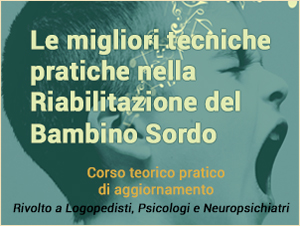Sommario:
- La riabilitazione percettiva di un soggetto disabile visivo
- Il bastone bianco: uno strumento semplice e civile
- Il desiderio di vedere
c. Il desiderio di vedere
1. Uno scomodo ospite
Il desiderio è un ospite ingombrante che non chiede permesso, non bussa alla porta per essere accolto nella nostra vita interiore.
Improvvisamente ce lo troviamo dentro già pronto a penetrare la nostra attenzione e la nostra volontà.
Spesso il desiderio non rispetta le nostre abitudini, le nostre convinzioni, l’immagine che abbiamo di noi stessi.
Esso ci sorprende, ci turba, mette a rischio le nostre sicurezze, ci costringe a guardare oltre l’orizzonte delle nostre esperienze.
Può accadere pertanto che il desiderio costituisca un’insidia per l’equilibrio della nostra esistenza, poiché ci spinge verso nuovi equilibri più incerti e meno conosciuti.
Per questa ragione il desiderio, soprattutto quando si manifesta con intensità, è accompagnato dalla paura e dal vacillamento della nostra abituale disinvoltura.
Accogliendo il desiderio noi entriamo in contatto con nuove realtà e veniamo costretti a camminare fuori dai sentieri ordinari, lungo percorsi avventurosi che generalmente esigono il potenziamento e il rinnovamento delle nostre capacità.
Allo scopo di respingere un desiderio che ci mette in crisi, noi ci concentriamo sulle paure che ci suscita. In questo modo ci separiamo dalle immagini del desiderio e riusciamo così ad allontanarle dal campo della nostra coscienza.
Ciononostante il desiderio non muore e in qualche modo continua a esercitare la sua forza intrusiva, condizionando comunque le nostre scelte e i nostri ragionamenti con la sua indomabile pressione dal profondo.
Quando i desideri repressi divengono troppi, rischiamo di essere governati dalle paure che fedelmente le accompagnano e dalle loro oscure pressioni.
In questi casi ci converrebbe chiedere aiuto per trovare la forza di estendere i confini della nostra coscienza per accoglierne almeno qualcuno, tra i desideri non riconosciuti.
Una volta nella coscienza, il desiderio può essere rappresentato, filtrato, mitigato, modificato, integrato nell’immagine che abbiamo di noi stessi.
Imparando a trattare i desideri sapremo anche offrire alla nostra esistenza un continuo processo di rinnovamento, non privo di fasi critiche ma confortato dalla fiducia nella nostra capacità di buon governo.
In definitiva sono i desideri che garantiscono alla nostra vita il senso della scoperta e del miglioramento.
2.Il desiderio nell’esperienza della perdita
Quando desideriamo intensamente qualcosa che abbiamo perduto, generalmente il desiderio presenta il suo volto più rigido e meno governabile.
Si tratta, infatti, di vivere ancora qualcosa di già vissuto, di rendere attuale un passato interrotto bruscamente, di recuperare un aspetto importante della nostra identità personale.
In questi casi si concilia più difficilmente con un processo di rinnovamento e può divenire un insidioso motivo di rifugio nella memoria.
A questo proposito coloro che perdono la vista rischiano di restare per anni, talvolta per sempre, degli ex vedenti che si comportano come sognatori di un tempo perduto, evitando i processi di adattamento e rincorrendo nei sogni ciò che la realtà non può più offrire.
In questo senso occorre comprendere come una protesi retinica non costituisca il recupero di una esperienza perduta, se non in misura molto parziale.
In ogni caso una protesi retinica non può prescindere da una complessiva risposta di adattamento da parte della persona non vedente.
In una simile prospettiva è necessario che il desiderio di vedere venga rielaborato in un contesto di cambiamento e di rinnovamento, nel quale il passato non può esigere la sua immodificabilità.
Curiosamente anche i non vedenti dalla nascita possono vivere l’esperienza visiva, in una dimensione fantastica e non cosciente, come un tesoro perduto per sempre che può essere riassaporato esclusivamente nella vita dei sogni.
In queste situazioni, proprio perché viene a mancare una memoria visiva, un’eventuale esperienza di adattamento verso forme di vista artificiale produce più che altro emozioni di sfiducia e di rinuncia.
Non è adattabile infatti qualcosa che vive in noi al di là della memoria, nella forma incontaminata e soprannaturale del mitologico.
Più realisticamente la vista potrebbe essere considerata come uno strumento, come un particolare tipo di finestra sul mondo. In questo modo essa si dimostra utilizzabile anche nelle forme più artificiali e parcellari.
3. Il desiderio nell’esperienza della curiosità
Quando desideriamo intensamente qualcosa che ci è stato precluso, il desiderio dimostra una maggiore adattabilità e può essere governato più facilmente.
In questi casi, infatti, il desiderio vive più che altro nel rapporto fra noi e il mondo, in un contesto di nuove conquiste e di nuove esperienze.
In altre parole la sua pressione è più erotica e meno narcisistica; è più rivolta verso gli oggetti della realtà e meno concentrata sulla rappresentazione del proprio sé.
Per queste ragioni, in simili circostanze, il desiderio di vedere si lascia modellare e modulare dalla logica del “si fa quello che si può” e del “meglio poco che nulla”.
Secondo questa logica l’esistenza assume una fisionomia più dinamica, anche se forse un po’ meno ordinata.
D’altra parte una quota sostenibile di disordine è la condizione che ci garantisce la libertà del cambiamento e del rinnovamento.
Quando l’ordine costituito si rispecchia in se stesso i motivi della perfezione e i motivi dell’esperienza rischiano di entrare in un conflitto insanabile e paralizzante.
Sempre nel più profondo rispetto per la sensibilità di ciascuno ritengo che le prossime forme di vista artificiale che ci verranno proposte, potranno offrirci interessanti e preziose esperienze sensoriali che ci aiuteranno a vivere meglio, offrendo per altro nuove opportunità di conoscenza e di studio delle funzioni sensoriali.