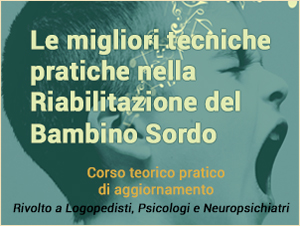Sommario:
- La riabilitazione percettiva di un soggetto disabile visivo
- Il bastone bianco: uno strumento semplice e civile
- Il desiderio di vedere
a. La riabilitazione percettiva di un soggetto disabile visivo
Considerazioni preliminari
La riabilitazione dei soggetti disabili visivi presenta una complessità così particolare da richiedere conoscenze, abilità e atteggiamenti che generalmente non possono trarre origine dall’attività intuitiva o dal ragionamento deduttivo.
In simili circostanze giova parlare di elevata specificità di un problema. Con questa espressione vogliamo appunto indicare un problema che, per essere affrontato con adeguatezza e con efficacia, esige accanto a conoscenze generali un’insieme di conoscenze concrete e di esperienze pratiche. Queste conoscenze e d esperienze consentiranno al tecnico della riabilitazione una vera e propria padronanza della situazione, per affrontare il caso nella sua singolarità, al di là di rigidi schemi o tipizzazioni, modulando l’intervento secondo le variabili ambientali e personali.
Quando il tecnico della riabilitazione viene a trovarsi di fronte al soggetto disabile visivo in una condizione di conoscenza generalizzata o addirittura generica, scarsa di informazioni concrete e pressoché priva di esperienze familiarizzanti, il suo intervento assumerà fatalmente una fisionomia stereotipata, secondo un criterio standard che certe volte risulta persino inappropriato sul piano della classificazione tipologica.
Infatti l’intervento riabilitativo andrebbe comunque sorretto da una consulenza e da una supervisione psicologica, svolta da un professionista esperto nei problemi connessi con la minorazione della vista.
D’altra parte occorre aggiungere che la riabilitazione dei soggetti disabili visivi presenta una dimensione molare (complessiva) che non si presta a semplificazioni riduzionistiche, mirate per così dire alla riattivazione e al potenziamento di un organo o di una singola funzione.
A questo proposito bisogna considerare con estrema attenzione che il maggiore pericolo presente nella crescita e nell’apprendimento di un soggetto disabile visivo consiste in uno sviluppo parcellare della personalità, labile nella coesione soggettiva dell’agire e dell’offrire significato all’azione.
E’ questa la ragione fondamentale per cui torna comunque opportuno concepire, per un soggetto disabile visivo, un progetto riabilitativo personalizzato, per altro ben concertato con il progetto educativo scolastico (ovviamente nel caso di età scolare).
Scivolando soltanto un attimo nel particolare, noi riteniamo che la riabilitazione visiva debba muoversi in un più ampio contesto di riabilitazione percettiva. In secondo luogo riteniamo che la riabilitazione percettiva non possa attuarsi efficacemente senza venire accompagnata da una riabilitazione delle funzioni immaginative e che tutto ciò non possa prescindere da una diffusa e lungimirante dimensione socioriabilitativa. Naturalmente ciò implica la capacità di integrare l’insieme dei servizi sociosanitari di assistenza, allo scopo di evitare il pericolo gravissimo dell’incongruità degli interventi.
D’altronde parlare di integrazione sociale di un soggetto disabile senza essere capaci di avviare concretamente l’integrazione dei servizi a suo favore, ci risulta davvero paradossale.
Nel processo di riabilitazione percettiva di un soggetto ipovedente possiamo distinguere quattro aspetti fondamentali, che sarebbe opportuno considerare complementari e sinergici:
1. Aiutare il soggetto ipovedente a conoscere il proprio residuo di funzione visiva, vale a dire la sua validità e la sua attendibilità
Generalmente si ritiene che un soggetto ipovedente possa conoscere e valutare l’utilizzabilità del proprio residuo di funzione visiva per apprendimento spontaneo. Viceversa egli ha bisogno d’essere aiutato a capire come ci vede da una persona che sappia capirlo insieme con lui, con semplicità e franchezza, senza atteggiamenti inquisitori o comunque perturbanti.
In questo senso i famigliari del bambino non vedente non sono spesso le persone più indicate a svolgere questa funzione, poiché mancano di competenza oftalmologica ed inoltre risultano molto condizionati dalla paura della cecità.
Con i famigliari il bambino ipovedente tende a mascherare il proprio limite visivo, simulando una condizione di apparente normalità. Più che altro egli apprende strategie di evitamento di tutte quelle circostanze che potrebbero evidenziare la sua limitazione visiva. Egli desidera placare l’ansia della famiglia e recuperare un clima relazionale più armonico ed espressivo.
Simili tentativi di mimetizzazione determinano frequentemente nel bambino una condotta instabile, caratterizzata da una notevole labilità dell’attenzione e da una persistente tendenza a fuggire dalle prove.
D’altra parte occorre considerare che i tentativi di mimetizzazione organizzano un conflitto interiore nella esperienza del bambino, il quale avverte la presenza del limite con le sue insidie, ma si sente costretto a fare come se il limite non ci fosse.
A questo proposito la funzione riabilitativa di un operatore tiflologico può riattivare nel bambino il desiderio di conoscersi, di conoscere e di essere conosciuto.
2. La socializzazione dell’esperienza visiva del soggetto ipovedente
Alcuni residui di funzione visiva presentano un elevato grado di complessità, soprattutto quando la riduzione dell’acutezza è accompagnata da restrizioni e disturbi del campo visivo.
Spesso i genitori esprimono impazienza ed irritazione di fronte al figlio ipovedente, proprio perché non riescono a comprendere la qualità del suo residuo di funzione visiva.
Talvolta i genitori sospettano addirittura che il figlio dica loro bugie, tanto risulta contraddittorio e incomprensibile il suo comportamento percettivo.
Logicamente una simile incomprensione non può che aggravare le circostanze di una situazione già drammatica e rendere ancora più difficile al bambino il tentativo di conoscere la validità e l’attendibilità della propria funzione visiva.
Pertanto occorre aiutare i famigliari del bambino ipovedente a comprendere bene la qualità del residuo. In tal senso le parole risultano spesso insufficienti a descrivere in modo comprensibile la condizione del bambino. Viceversa l’uso di materiale fotografico, opportunamente confezionato, può costituire una esemplificazione più immediata e valida, tale da indurre un’efficace comprensione.
Provvedere ad una soddisfacente produzione di simile materiale fotografico, quantomeno riferito alle più frequenti tipologie di residuo visivo, potrà certamente giovare in misura molto sensibile.
3. Il potenziamento del residuo di funzione visiva
Da un punto di vista propriamente psicologico il potenziamento del residuo di funzione visiva deve essere considerato soprattutto come un cambiamento a cui adattarsi.
E’ vero che i cambiamenti, quando comportano piacere e miglioramento, sono molto più facili da assimilare. Ciò nonostante giova considerare che l’euforia di un miglioramento, non ancora ben conosciuto e ben governato, può talvolta generare comportamenti inadeguati, da cui potrebbero scaturire conseguenze nocive.
Nel caso specifico di un soggetto ipovedente che improvvisamente migliori la propria capacità visiva, occorre promuovere e facilitare il rinnovamento della sua consapevolezza circa il patrimonio percettivo a sua disposizione, affinché possa conoscere serenamente le nuove possibilità ed anche i nuovi limiti.
4. La riabilitazione percettiva nella sua globalità
La riabilitazione del residuo di funzione visiva dovrebbe essere intesa nel contesto più ampio e complessivo di una vera e propria riabilitazione senso-percettivo-motoria.
Infatti soprattutto nei soggetti ipovedenti, cosiddetti “subefficienti visivi”, si tratta di promuovere l’apprendimento di una molteplicità di strategie e di condotte percettive, in relazione con le diverse attività da svolgere e con la diversità dei contesti nei quali tali attività verranno svolte.
Questi soggetti presentano un residuo visivo relativamente consistente, molto valido in alcune circostanze e scarsamente valido in altre. Considerando l’ambivalenza di un simile residuo, dovremmo evitare di assumere atteggiamenti poco equilibrati, cercando semplificazioni riduttive, certamente non rispettose del volume di possibilità presenti nella condizione percettiva del soggetto.
Generalmente il desiderio di semplificare scaturisce sia dal bisogno di affermare a tutti i costi l’apparenza di normalità del soggetto, sia dal bisogno di affermare “la sostanziale cecità” del soggetto, liquidando così i difficili problemi derivanti dalla presenza del residuo di funzione visiva.
In questa seconda eventualità prevale il desiderio di rifugiarsi in una diversità più grave ma anche più semplice, più conosciuta e più culturalizzata.
Evidentemente in entrambi i casi vengono trascurate le possibilità reali presenti nel soggetto, sacrificando la complessità della sua condizione ai nostri bisogni di sistemazione mentale.
Proprio per questa sua drammatica e difficile ambiguità percettiva, un soggetto ipovedente ha bisogno di un servizio di riabilitazione intelligente e flessibile, capace di rispecchiare e di potenziare le sue possibilità ed i suoi limiti, lungo un percorso di miglioramento graduale, nel quale il limite possa divenire uno stimolo per conoscere, un confine da estendere, una barriera da eludere e talvolta da scavalcare.