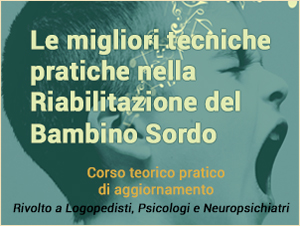Sommario:
- Incidenza della minorazione visiva sullo sviluppo affettivo
- La cecità, una condizione di complesso equilibrio
- L’esperienza corporea nello sviluppo del bambino disabile visivo
- Solo per amore
c. L’esperienza corporea nello sviluppo del bambino disabile visivo
Per comprendere l’esperienza corporea di un bambino non vedente occorre mettere a fuoco un insieme di considerazioni che scaturiscono principalmente dalle particolari caratteristiche della relazione con sua madre, una relazione che possiamo definire di eccessiva appartenenza.
Il corpo del bambino non vedente appartiene a sua madre in una misura maggiore di quanto non accada nel caso degli altri bambini normodotati.
Soprattutto il senso di colpa, la preoccupazione, il desiderio di riparare inducono la madre a rafforzare l’attaccamento con il figlio, anche quando la sua condotta appare caratterizzata dal rifiuto.
Infatti il rifiuto riguarda la disabilità del bambino, la sua privazione sensoriale e non la sua realtà corporea, vissuta dalla madre come parte di sé stessa, benché frustrante e angosciante.
Perfino nei casi di maltrattamenti non dovremmo parlare di rifiuto, ma di attacco alla minorazione del bambino che, inteso come parte della madre, può essere attaccato soltanto in un contesto di autolesionismo.
La significativa incidenza della psicosi simbiotica nel caso di bambini non vedenti o gravemente ipovedenti, rappresenta una delle estreme conseguenze di un eccesso di appartenenza reciproca.
E’ forse un bene precisare che il sentimento di appartenenza costituisce il fondamento del nostro sviluppo, la condizione stessa della nostra nascita psicologica e della nostra esistenza personale.
E’ pertanto l’eccesso di tale sentimento che non consente al bambino di organizzare la propria solitudine e di costruire adeguatamente la propria realtà individuale.
Il più delle volte il bambino non vedente vive le cure materne nell’intensità di una preoccupazione ansiosa, in un contesto di necessaria riparazione.
In questo modo le cure materne possono divenire un vero e proprio atto magico di riparazione e di negazione fantastica del limite sensoriale.
Per quanto disancorato dal sentimento di realtà il piacere della madre di occuparsi con estrema dedizione del corpo del figlio, ricavandone un immenso piacere liberatorio, può divenire per il bambino cieco un riferimento obbligato ed una condizione permanente di orientamento per la sua esperienza corporea.
In altre parole il suo corpo, invece di divenire uno strumento di conoscenza del piacere, viene vissuto come oggetto di ansia, di cura e di piacere liberatorio dal confronto con il limite.
D’altra parte questo attaccamento eccessivo tra la madre e il bambino non vedente riduce sensibilmente lo spazio della relazione coniugale, sollecitando spesso nel padre risposte di chiusura e di evitamento che accentuano oltremodo l’isolamento della relazione madre-bambino.
Da un lato il padre si sente tradito nella relazione coniugale da una moglie che si occupa quasi interamente del figlio non vedente, d’altro lato egli vive la necessità e il dovere di fare qualcosa anche lui per il figlio disabile e generalmente se ne occupa per quegli aspetti che potremmo definire tecnico-finanziari.
In simili circostanze familiari il bambino non vedente tende a crescere in una condizione di iperdipendenza, nella quale rappresenta la propria realtà personale accompagnata tacitamente da una presenza complementare che lo solleva dal confronto con le difficoltà attraverso cure, attenzioni e prestazioni costanti.
Anche la relazione con il suo corpo sarà naturalmente mediata da questa presenza complementare e ciò impedirà al soggetto non vedente, in misura più o meno grave, la possibilità di indossare e di vivere il proprio corpo come un’esperienza privata e personale, frutto di ricerca e di sperimentazione individuale.
Attualmente accade con sempre maggiore frequenza che i ragazzi disabili visivi, spinti da una sorta di orgoglio ferito, vogliono combattere e negare questa loro condizione di iperdipendenza.
Si tratta di una protesta velleitaria tale da indurre atteggiamenti e comportamenti incoerenti e difficili da comprendere da parte degli amici o di eventuali partners.
Simili condotte assunte per mera velleità conducono verso un ulteriore complicazione del rapporto con sé stessi e, prima o poi, determinano situazioni insostenibili, così pesanti da suggerire la chiusura e la rinuncia.
Per essere superata, la condizione dell’iperdipendenza ha bisogno di essere riconosciuta, vissuta e ridotta progressivamente.
Per questa ragione i ragazzi non vedenti hanno soprattutto bisogno di essere aiutati a divenire amici di sé stessi e a comprendere il significato storico delle loro manchevolezze, al di là sterili e distruttivi giudizi di merito.
Per camminare lungo la difficile strada che ci conduce verso una progressiva riduzione dell’appartenenza e della dipendenza, occorre poter vivere l’opportunità di nuovi spazi socioesperienziali, almeno in parte esterni all’area psicoculturale della famiglia.
A questo proposito occorre comprendere che perlopiù si tratta di spazi sociali non graditi o poco graditi dai familiari del soggetto non vedente proprio perché sfuggono alla possibilità di un controllo, accentuando ansia e preoccupazione.
Per consentire simili esperienze liberatorie di rinnovamento e, allo stesso tempo, evitare eccessivi strappi da una dipendenza che mantiene pur sempre la sua funzione ed il suo significato, una prudente mediazione istituzionale, svolta ad esempio dall’Unione Italiana Ciechi, può risultare preziosa e risolutiva.
Sia ben chiaro però, si tratta di avere la capacità di rispettare tutti i valori in gioco, senza sacrificare sbrigativamente la sensibilità e il vissuto di ciascuno dei partecipanti.
Tutto questo naturalmente in funzione della crescita del ragazzo non vedente, affinché possa integrare la propria esperienza e divenire effettivamente protagonista del suo processo di integrazione sociale.
In tale contesto di evoluzione, il ragazzo non vedente potrà conoscersi meglio, comporre in modo più equilibrato la rappresentazione di sé stesso e conquistare una prospettiva di vita sociale che rispetti e contemperi le realtà contraddittorie della sua personalità.
Vorrei dire che lungo questa via solo praticamente inevitabili le aberrazioni e gli eccessi. Più che cercare di evitarli, occorre saperli riconsegnare e presentare al ragazzo non vedente nel loro significato processuale, sdrammatizzando nell’errore l’emozione tragica dell’irreparabile.
Naturalmente questo ci conduce a concepire la necessità di una consulenza per i ragazzi non vedenti e per i loro genitori. E’ importante concepire una consulenza che non entri quasi mai nel merito del che fare, ma si limiti a favorire, attraverso gli strumenti socratici dell’ironia e della maieutica, il processo di crescita appena descritto.
Sul piano culturale mi sia consentito affermare, in sede di conclusione, che in buona sostanza sono tre gli errori che attualmente caratterizzano, nella forma implicita dell’inconsapevolezza, il nostro costume associativo.
In primo luogo continuiamo a combattere l’iperdipendenza e l’iperprotezione con lo stile di chi combatte un nemico, senza comprendere che si tratta in definitiva di condizioni e di atteggiamenti che vanno mitigati ed anche combattuti, ma pur sempre nel rispetto di relazioni interpersonali che trovano il loro giusto fine in una sempre migliore conoscenza reciproca.
In secondo luogo stiamo cercando di inserirci nella realtà culturale del visualismo senza affermare con la necessaria grinta il bene sensoriale e immaginativo presente nella nostra condizione. In particolar modo, è il tatto e l’immaginazione dei ciechi che vengono squalificate da questo nostro atteggiamento, che potremmo definire di aspiranti vedenti.
Naturalmente il desiderio di vedere deve occupare un posto significativo nella nostra condotta sociale, ma ciò non può divenire un elemento che peggiora l’immagine della nostra condizione reale.
In terzo luogo, ma è l’aspetto più importante, dovremmo concepire con maggiore lucidità che è la persona non vedente il principale e insostituibile protagonista del suo confronto con il limite sensoriale della cecità.
Noi possiamo, così come stiamo facendo, creare opportunità preziose ed anche entusiasmanti allo scopo di favorire questo confronto per renderlo più sostenibile.
Dobbiamo però tenere presente che tra queste risorse e opportunità, che noi costruiamo con impegno e con tenacia, la più efficace resta pur sempre il colloquio educativo.
La società, proprio perché ci vuole bene in modo sbagliato, è fin troppo contenta di vederci “aspiranti vedenti” e di accogliere con faciloneria questo nostro desiderio per poi magari lasciarci un po’ più soli nel momento del naufragio.
Per questa ragione può inserirsi e integrarsi in una simile società soltanto un soggetto non vedente che sia divenuto amico di sé stesso e che abbia saputo concepire una risposta personale alla sua limitazione visiva.
Ragionevolmente, senza trascurare nessun altro settore delle nostre importanti attività, cerchiamo di potenziare questa nobile e prioritaria funzione educativa, che ha rappresentato e potrà continuare a rappresentare la cima più alta dalla quale osservare il cammino storico dei ciechi ed il miglioramento della loro esistenza.