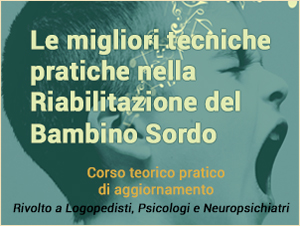Sommario:
- Incidenza della minorazione visiva sullo sviluppo affettivo
- La cecità, una condizione di complesso equilibrio
- L’esperienza corporea nello sviluppo del bambino disabile visivo
- Solo per amore
a. Incidenza della minorazione visiva sullo sviluppo affettivo
1. Introduzione
Naturalmente l’affetto nasce in famiglia poiché la sua origine osservabile coincide con le prime ed arcaiche esperienze di attaccamento. Infatti il bambino si accosta alle figure di riferimento e qualora si trovi da esse troppo lontano segnala in vario modo la sua presenza per essere avvicinato. Siamo soliti chiamare affetto la ricerca della vicinanza ed in particolar modo la ricerca del contatto corporeo. Volendo precisare, dovremmo distinguere nell’esperienza affettiva la manifestazione dell’amore dalla manifestazione dell’odio. In un certo senso anche nell’odio possiamo percepire la ricerca della vicinanza e del contatto. Ma una simile ricerca è finalizzata a colpire l’altro per distruggerlo o quantomeno per danneggiarlo. Questa distinzione ci mostra subito l’affetto nella sua complessità e nella sua ambivalenza. Il contrario dell’affetto è quindi il disinteresse, l’estraneità vale a dire la mancanza più o meno totale di sensibilità e di attenzione. Ma cosa vogliamo intendere quando parliamo di sviluppo affettivo, di autonomia affettiva, di superamento della dipendenza?
Non è certamente facile rispondere a questa domanda senza rifugiarsi nel linguaggio tecnico della psicologia. In parole semplici possiamo dire che dimostrano una buona competenza affettiva tutti coloro che sanno avvicinarsi, allontanarsi, riavvicinarsi ad una persona cara senza vivere in queste esperienze di mutamento della situazione affettiva eccessivi turbamenti e dispendio di energia. Se mi chiedeste di quantificare l’aggettivo «eccessivi» mi troverei piuttosto in crisi poiché tale aggettivo dovrebbe essere considerato più che altro nel contesto singolare di una situazione personale intesa nella sua interezza e nella sua particolare fisionomia. Non esistono pertanto precise regole logico-matematiche per definire con chiarezza e misura l’insorgenza dell’eccessivo nella sfera emozionale. Esistono però disturbi che dimostrano con evidenza la presenza di notevoli difficoltà nel mondo degli affetti. Spesso simili disturbi producono conseguenze nocive sulla capacità di conoscere e di agire. Soprattutto in questi casi possiamo parlare di eccesso con un sufficiente grado di oggettività poiché quando l’affetto nuoce alla capacità di conoscere e di agire diviene un vero e proprio ostacolo per lo sviluppo e per l’apprendimento, rischiando così di compromettere il processo di liberazione e di realizzazione umana. Logicamente un limite sensoriale non può non incidere sullo sviluppo della dimensione affettiva perché riduce nel soggetto la possibilità di venire attratto dal mondo circostante riducendo in misura più o meno grave il campo percettivo. Nel caso particolare della minorazione visiva, il campo percettivo viene molto ridotto tanto da determinare una emozione di perdita piuttosto rilevante. Naturalmente nel caso del bambino cieco nato la riduzione del campo percettivo viene a presentarsi come un dato di fatto che verrà vissuto come perdita soltanto dopo l’ingresso del limite sensoriale nella sua coscienza. In ogni caso possiamo dire che la mancanza della vista genera rischio psicopatologico, ma di per sé non compromette l’organizzazione di una buona relazione oggettuale tra il bambino e la realtà che lo circonda. In simili circostanze diviene più importante la qualità delle caratteristiche ambientali e soprattutto la qualità delle risorse umane presenti nel suo ambiente familiare e sociale. In altre parole, le risorse presenti nel soggetto nel quale insorge il danno visivo, l’atteggiamento e la condotta dei suoi familiari, l’integrazione culturale dell’ ambiente di appartenenza risultano spesso così importanti da apparire decisivi circa gli effetti derivanti dalla minorazione visiva. Per questa ragione c’è un accordo generale tra gli studiosi nell’affermare che i cosiddetti effetti collaterali della minorazione visiva costituiscano il problema prevalente quando si parli di incidenza della minorazione visiva sullo sviluppo della personalità.
2. L’esperienza di avvicinamento e di fusione
Durante la primissima infanzia il bambino non vedente viene solitamente osservato con atteggiamento inquisitorio ed ansioso poiché i familiari indagano sulla sua funzione visiva ed anche sulla sua condotta affettiva. Da parte loro i familiari non vorrebbero credere alla sconcertante realtà della minorazione. Vivendo oscuramente la realtà dell’evento negativo essi si chiedono se il figlio nutra buoni sentimenti nei loro confronti. In particolar modo la madre cerca di comunicare con il figlio non vedente ma i suoi tentativi di avvicinamento e di fusione sono spesso contratti dalla preoccupazione di non essere accolta e desiderata dal suo bambino. Occorre inoltre considerare che una simile preoccupazione limita le capacità intuitive della madre che non riesce a trovare le modalità gestuali e vocali per comunicare con il bambino in una forma corrispondente alle sue specifiche esigenze. Spesso, inoltre, la madre non riesce a comprendere il comportamento senso-motorio-percettivo del figlio e soprattutto fraintende la sua condotta di attenzione percettiva interpretandola come una manifestazione di rifiuto. Da parte sua il bambino non vedente ha bisogno, come tutti gli altri bambini, di essere accolto e riconosciuto così com’è a partire dalla sua realtà sensoriale. Tutto questo può facilmente danneggiare l’esito di un avvicinamento primario tra madre e bambino determinando, secondo i casi, un’esperienza di fusione insufficiente oppure inadeguata. In alcuni casi accade che la madre enfatizzi la comunione con il figlio non vedente e conquisti tale fusione mediante un comportamento iperattivo che in qualche misura ritarda e danneggia lo sviluppo della sua individualità. In altri casi accade che la madre non riesca a praticare l’avvicinamento in una misura adeguata e soddisfacente, determinando nello sviluppo del bambino la comparsa di un io precoce e disfunzionale soprattutto per quanto concerne gli aspetti sociorelazionali.
3. La qualità della partecipazione e l’esperienza di allontanamento
Circa l’esperienza di allontanamento può giovare una chiarificazione su alcuni aspetti preliminari. In primo luogo con la parola «allontanamento» non vogliamo intendere soltanto l’aumento della distanza corporea e percettiva ma anche l’aumento della distanza emozionale, vale a dire, la distinzione della differenza tra le proprie emozioni e l’emozioni dell’altro.
In secondo luogo è bene precisare che qui parliamo della capacità di allontanarsi conservando comunque una buona emozione della persona cara da cui ci allontaniamo oppure, in ogni caso, un’emozione non buona ma riparabile. Quando ci si allontana dall’altro con emozioni negative e vissute come irreparabili sarebbe infatti meglio parlare di separazione angosciosa e non di allontanamento. Nel momento di allontanarsi il bambino non vedente vive due difficoltà fondamentali, entrambe vincolate direttamente con il suo specifico limite sensoriale. Da un lato egli può allontanarsi soltanto se conosce l’ambiente in misura tale da intraprendere un percorso conosciuto e riconoscibile; d’altro lato egli, mentre si allontana, non può osservare l’atteggiamento e l’espressione dell’altro nei suoi confronti. Evidentemente si tratta di limiti che possono essere neutralizzati da un ambiente familiare educativo capace di corrispondere alle sue esigenze con efficacia e con serenità. Viceversa accade spesso che i familiari non vogliano e non sappiano promuovere l’allontanamento del bambino soprattutto perché non riescono a concepirlo come una persona intera verso cui nutrire propensione e stima. Continuando a considerare il bambino non vedente come una parte di sé, i genitori negano al figlio il piacere di una partecipazione attiva, trattenendolo in una condizione indistinta di mescolamento dei comportamenti e delle emozioni. Nel caso particolare di un bambino non vedente che abbia strutturato un io precoce e inadeguato, bisogna dire che purtroppo il problema dell’allontanamento non può esistere in quanto non ci può essere allontanamento in una condizione nella quale non ci sia stato prima un rapporto di vicinanza e di fusione.
4. Il riavvicinamento e l’esperienza della riparazione
Soprattutto quando l’aumento della distanza abbia prodotto nell’esperienza tra due persone legate da affetto un considerevole turbamento, ci si trova di fronte al problema del riavvicinamento. Logicamente anche qui la parola «riavvicinamento» non va intesa nel suo significato esclusivamente spaziale ma nel suo significato totale di rinnovamento dell’offerta di sé mediante un gesto, un atteggiamento, un’iniziativa capace di esprimere il senso intimo e profondo del dono. I principali ostacoli che si oppongono alla volontà di riavvicinarsi sono l’orgoglio che non ci fa tollerare la probabilità di un rifiuto ed il senso di colpa che ci fa sentire imperdonabile e irreparabile l’avvenuto allontanamento. Anche in una simile circostanza il bambino non vedente incontra una difficoltà in più. Nel momento in cui si sta riavvicinando, egli non può facilmente percepire nell’espressione dell’altro i segnali mimico gestuali dell’accoglienza e si trova pertanto costretto ad affrontare la probabilità di un rifiuto mediante modalità di comunicazione meno graduali e meno interagenti. Se consideriamo, inoltre, che spesso nella famiglia del bambino non vedente l’emozione della colpa continua a perturbare il flusso circolare della comunicazione, possiamo dire che l’iniziativa del riavvicinamento sulla base di questi presupposti sia personali che ambientali appare piuttosto difficile e inquietante.
5. La funzione della scuola nello sviluppo affettivo dell’alunno disabile visivo
Generalmente quando pensiamo allo sviluppo affettivo di un bambino, non ci viene spontaneo
immaginare l’istituzione scolastica interessata da questa problematica in misura importante e decisiva.
Questo accade perché siamo molto abituati a pensare che lo sviluppo affettivo trovi le sue fortune ed anche le sue disgrazie nel contesto della famiglia, dove l’affetto nasce, si sviluppa e trova le sue risposte più significative e rilevanti.
D’altra parte è anche vero che siamo ugualmente abituati a concepire lo sviluppo dell’affetto e lo sviluppo della conoscenza come due percorsi sostanzialmente paralleli, che interferiscono accidentalmente in circostanze davvero straordinarie.
A questo proposito il pensiero psicologico più evoluto considera ormai lo sviluppo affettivo e lo sviluppo della conoscenza quasi come due astrazioni da un intreccio di forze interagenti e interdipendenti.
In altri termini, così come un turbamento affettivo può divenire un ostacolo per le funzioni dell’apprendimento, nello stesso modo una riattivazione del gusto di apprendere costituisce di fatto un vero e proprio recupero dal punto di vista affettivo, anche nel senso di una rigenerazione del buon umore di base.
Non è difficile intuire come nel caso del bambino non vedente tutto questo divenga ancor più vero ed importante.
Promuovendo e sostenendo nel bambino non vedente il piacere della conoscenza, l’abitudine attiva ad apprendere, la scuola rinnova e moltiplica la sua possibilità di contatto, di vicinanza con il mondo circostante, nei suoi aspetti sociali e naturali.
Questo processo, apparentemente confinato nella dimensione del conoscere, può rigenerare e addirittura potenziare la competenza affettiva del bambino non vedente, poiché consente alla sua immaginazione di concepire nuove forme di fusione affettiva, di allontanamento sostenibile e di riavvicinamento generoso.
A questo proposito potremmo dire che la cultura, quando viene costruita nel tessuto della vita quotidiana, alfabetizza le nostre capacità di viver con gli altri e tra gli altri, fluidificando atteggiamenti e comportamenti che risultavano troppo spigolosi e intrattabili.
Bisogna inoltre aggiungere che la funzione delle istituzioni scolastiche in questo senso può andare oltre i limiti di queste prime considerazioni.
Infatti nella finalità scolastica dell’istruzione educativa è compreso un servizio di accoglienza, di riconoscimento, di offerta di appartenenza, di presentazione del mondo e di facilitazione ad esistere che rappresentano il volto più sociale e la dimensione più civile della funzione materna
Il fatto che la scuola svolga un ruolo diverso dal ruolo della famiglia non dovrebbe indurci a pensare che questi ruoli, benché distinti, possano essere considerati estranei.
Soprattutto nella loro dimensione educativa, la famiglia e la scuola possiedono una comune finalità che consiste nell’orientamento della crescita e dell’esistenza del bambino, mediante l’acquisizione di abitudini, attitudini e competenze adeguate a facilitare in lui, nei limiti del possibile, l’apprendimento più difficile, vale a dire, l’arte del vivere.
Forse oggi più che mai risulta difficile orientarsi nel mondo della vita, poiché esso ci appare particolarmente intricato e labirintico.
Per costruire una conciliazione con la complessità di un simile mondo, occorrono certamente strumenti cognitivi molto evoluti, ma occorre soprattutto la capacità di estendere e di articolare la nostra personale disposizione affettiva.
Per altro ciò è possibile solo attraverso una scuola che sappia avvicinare l’esperienza del conoscere con le emozioni positive.
Molto più degli altri, il bambino non vedente rischia di restare confinato nel mondo degli affetti primitivi, vivendo l’uscita da questi suoi confini soltanto come una spiacevole necessità, talvolta come una parentesi più o meno angosciosa. Se consideriamo che le persone non vedenti hanno saputo manifestare le loro migliori possibilità soprattutto nella realtà del lavoro e della ricerca, immaginiamo meglio l’importanza di una scuola capace di alimentare l’interesse del bambino cieco nel confronto con la vita sociale.
Il lavoro e, più in generale, l’operosità rappresentano il vero e proprio cardine per la vita affettiva della persona che non vede. In altre parole egli ha bisogno di mitigare l’iperdipendenza mediante una capacità di agire in modo incisivo ed efficace, per poter vivere il sentimento d’appartenenza con la forza della partecipazione soggettiva.
In questo senso bisogna dire che la scuola spesso si preoccupa troppo di offrire qualcosa al bambino non vedente, sorvolando e trascurando ciò che viceversa dovrebbe chiedere alle sue possibilità.
Un affetto passivo e inoperoso non riesce ad esprimere neanche la riconoscenza, poiché respira con angustia il suo attaccamento morboso.
Offriamo quindi ai bambini non vedenti la possibilità di vivere un’esperienza affettiva estesa e lungimirante, tale da conferire alla sua eccessiva dipendenza sociale il volto soggettivo dell’operosità e della responsabilità. In questo modo potremo consolidare l’equilibrio del suo sviluppo ed inoltre potremo sostenere la sua personale ricerca della felicità.