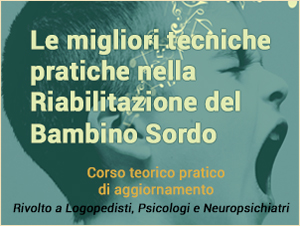Sommario:
- Una questione non risolta
- Due condizioni da distinguere
- Occhio non vede, cuore non vuole
- L’esperienza del bello multimediale
- Il sole continua a sorgere per tutti noi
c. Occhio non vede, cuore non vuole
Sono gli occhi che ci fanno sentire il mondo attraente, offrendoci la bellezza delle sue forme viventi e le maliziose tentazioni dell’orizzonte.
Gli occhi ci consentono di scorgere gli oggetti del desiderio e la nostra vita diviene azione, ricerca, progetto.
D’altra parte essi ci mostrano alcune ripugnanti brutture della realtà che francamente sarebbe molto meglio non vedere.
La privazione della vista preclude entrambe le vie e conferisce alla vita mentale una pace, una chiarezza che rendono spesso il cieco capace di cogliere le verità profonde, fino a raggiungere la condizione della chiaroveggenza.
Infatti il cieco non viene distratto o confuso dalle forme della vita esteriore e può concentrarsi sulla realtà umana osservando attraverso una luce spirituale ciò che gli altri non possono vedere.
Queste affermazioni rappresentano in sintesi uno tra i pregiudizi più antichi e suggestivi che dipingono la figura della persona non vedente.
Volendo prescindere dai presupposti filosofici che orientano tale pregiudizio, qui ci interessa soprattutto mettere a fuoco la grave tesi che lo ispira in forma tacita e vistosa.
“Proprio perché sono incapaci di percepire la manifestazione espressiva del mondo, degli altri e perfino di se stessi, i soggetti non vedenti sono incapaci di amare.
Essi vengono a contatto con le verità più profonde dell’animo umano, restando però separati dalle dinamiche dell’azione e dalle esperienze relazionali”.
Secondo una simile concezione pregiudiziale, la condizione di cecità consente un contatto con la verità, soprattutto nella sua dimensione ultramondana, ma non consente il contatto con la bellezza e neppure con la bontà, volendo escludere i suoi aspetti più utilitaristici.
Proprio perché si tratta di un pregiudizio, non può risultare sufficiente una contestazione condotta sul filo del ragionamento e sulla base di un sereno esame della realtà.
Occorre piuttosto ricercare l’efficacia del convincimento nel contesto dell’esperienza interpersonale, dimostrando con i fatti una competenza sociorelazionale in grado di penetrare nell’altro oltre i limiti del pregiudizio.
Parafrasando l’espressione con la quale Augusto Romagnoli esortava i ciechi ad essere amabili, potremmo dire: “Dimostrate agli altri di saper amare, poiché soltanto ciò potrà dissolvere questo arcaico e persistente pregiudizio negativo”.
Ma per dimostrare di essere capaci di amare, cosa bisogna saper fare? Quali sono gli ingredienti dell’amore? Quali le modalità più efficaci?
L’esigenza di offrire una risposta ordinata e sintetica ci costringe in qualche modo a formulare uno schema che naturalmente presenterà i limiti caratteristici della semplificazione logica.
Il desiderio di conoscere, la disposizione ad accogliere l’immagine che l’altro ci offre di sé stesso, la capacità di esprimere i propri bisogni, la concezione di un possibile miglioramento di sé stesso e dell’altro costituiscono i cardini intorno ai quali può evolvere ed assumere consistenza il sentimento dell’amore.
Nel suo significato più radicale il desiderio di conoscere rappresenta il superamento di un attaccamento esclusivo, con il quale il bambino resta confinato nell’ambito degli affetti materni e familiari.
In altre parole il desiderio di conoscere può essere definito come l’interesse diffuso nello spazio e nel tempo, la curiosità rivolta verso gli oggetti del mondo.
Naturalmente un simile sentimento presuppone la disposizione ad incontrare nuovi oggetti d’amore e a rinnovare la propria relazione con la realtà.
Frequentemente constatiamo che il bambino cieco non possiede questo sentimento, ma generalmente ciò dipende dagli effetti collaterali di una diseducazione involontaria.
D’altra parte la fiducia, l’autonomia e l’iniziativa sono carenti in tutti quei bambini che non hanno l’opportunità di sviluppare le proprie competenze cognitive e affettive.
In particolar modo il bambino cieco deve poter credere nell’efficacia dei propri mezzi di conoscenza, per desiderare di conoscere il mondo, gli altri, se stesso.
Priva di tali requisiti una persona, cieca o vedente che sia, ci appare spenta, reclusa nei propri condizionamenti, incapace di offrire gratitudine all’esperienza del vivere.
In secondo luogo la capacità di accogliere l’immagine che l’altro ci comunica di se stesso dipende soprattutto dalla qualità del nostro sviluppo sociale.
Molti fra noi vivono la comunicazione come uno spazio relazionale nel quale occorre occupare il centro, per non essere costretti dall’altro ad ascoltare cose che ci turbano, fatti che ci distraggono, pensieri ed emozioni che potrebbero cambiarci.
Questa posizione egocentrica risulta generalmente fastidiosa, talvolta risulta affascinante, ma non può mai risultare amorevole.
Nell’amore infatti noi siamo conquistati dall’altro, che regna sovrano nella nostra immaginazione ed occupa uno spazio relazionale coerente con le proprie esigenze.
Questa disponibilità comunque non deve essere intesa come una condizione passiva di subordinazione.
Si tratta viceversa di una subordinazione attiva, vivace, convincente, ispirata e nutrita dal desiderio di conoscere l’altro.
Di per se la cecità non impedisce lo sviluppo di questa disposizione, ma certamente un contesto ambientale frustrante o eccessivamente protettivo può limitarla in misura significativa.
In terzo luogo la capacità di esprimere i propri bisogni rende più stabile ed equilibrato il sentimento dell’amore, poiché da solo il desiderio può indurci a prendere un’eccessiva distanza dal confronto con i limiti della realtà.
La capacità di esprimere i propri bisogni scaturisce dalla consapevolezza dei nostri limiti e dal confronto con essi.
D’altra parte il confronto con il limite non può e non deve reprimere il desiderio di oltrepassarlo e di estendere progressivamente i suoi confini.
Questa dialettica tra bisogni e desideri offre significati e dinamismo alla nostra vita, regolando il suo flusso tra le sponde della dipendenza e della libertà.
Una persona che senta eccessivi i propri bisogni può essere facilmente indotta a fuggirne, vivendo a quel punto il desiderio come alienazione dalla propria realtà personale.
In ultima istanza la capacità di concepire il proprio miglioramento e il miglioramento dell’altro dipendono in misura preponderante dalla speranza di vivere in un mondo migliore e dalla capacità di immaginarne almeno alcuni aspetti.
Questa tensione ideale rappresenta forse più di ogni altra la condizione dell’umanità, che attraverso simboli differenti e mutevoli e nonostante la forza delle abitudini non ha mai cessato di pensare al meglio, immaginando la sua realizzazione.
Coloro che mancano di questa speranza potranno certamente vivere le attrazioni magnetiche del mondo e degli altri, ma non potranno trasformare queste attrazioni in una qualsiasi forma evolutiva del vivere insieme.
Come si può facilmente constatare la mancanza della vista non può costituire di per sé un ostacolo alla maturazione della capacità di amare, anche se gli effetti della diseducazione involontaria continuano a danneggiare in misura preoccupante lo sviluppo dei bambini non vedenti e gravemente ipovedenti.
Enrico Ceppi diceva spesso che occorre in primo luogo aiutare il bambino non vedente a divenire amico di sé stesso. Essere amici di sé stessi ci consente di osservare la realtà con maggiore equilibrio e soprattutto di scorgere le opportunità in essa presenti.
In ultima analisi è questa la virtù che più frequentemente viene a mancare nella persona non vedente, che non abbia ricevuto dall’ambiente educativo fiducia, accoglienza e riconoscimento.
Aiutiamo pertanto i bambini non vedenti a innamorarsi della realtà e potremo così superare, in una sola volta, la loro chiusura e l’altrui pregiudizio.