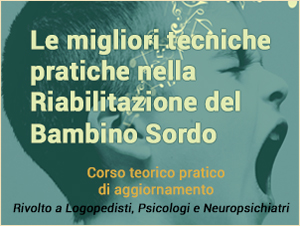Sommario:
- L’esperienza di apprendimento scolastico degli alunni sordi tra classi speciali e ordinarie
- Linguaggi comunicazione ed esperienza
- Gli studenti disabili sensoriali nelle università: verso un percorso di apprendimento personalizzato
c. Gli studenti disabili sensoriali nelle università: verso un percorso di apprendimento personalizzato
1. Ascoltare i sordi e osservare i ciechi: opportunità per nuove conoscenze
La condizione umana e sociale dei soggetti disabili sensoriali presenta rilevanti caratteri di complessità funzionale, tali da richiedere a chi voglia comprenderne il profilo dinamico e le problematiche, eccellenti capacità di osservazione, di ragionamento e di equilibrio emozionale.
Almeno per un aspetto possiamo dire che i ciechi e i sordi hanno commesso il medesimo errore nel corso della loro faticosa, difficile ed ancora incompiuta integrazione socioculturale.
I ciechi hanno cercato la socializzazione delle loro esperienze personali, comunicando soprattutto attraverso l’uso della parola, lo strumento di cui dispongono senza limitazioni.
Analogamente i sordi hanno cercato di raggiungere il medesimo obiettivo, comunicando soprattutto mediante la realtà dell’agire e del sentire, nella sua immediatezza espressiva, vale a dire attraverso strumenti padroneggiati con naturalezza.
In entrambi i casi il risultato è stato significativo ma insufficiente.
Con le loro parole, i ciechi hanno saputo magnetizzare l’attenzione degli altri, ma non sono riusciti a costruire con essi un soddisfacente e comune sentimento di realtà. Ancora oggi le loro parole vengono vissute in una dimensione di patos inoperoso, affascinante ma svincolato dalle pratiche del vivere quotidiano.
D’altro lato le azioni e la mimica dei sordi vengono percepite con occhio superficiale e bidimensionale, appiattito sulla concretezza immediata del contesto, al di qua dello spessore personale del soggetto non udente.
Potremmo dire che i ciechi hanno bisogno di essere osservati maggiormente nella dimensione dell’agire, mentre i sordi meritano maggiore ascolto e intelligenza per quanto concerne i loro pensieri e la loro vita interiore.
Affinché ciò possa avvenire occorre educare gli uni e gli altri in tale direzione ed in particolar modo verso una consapevolezza dei loro limiti sensoriali ed anche dei limiti incontrati dagli altri nel tentativo di comprendere la loro condizione.
Nel caso dei soggetti disabili sensoriali la consapevolezza del limite costituisce il vero e proprio cardine di uno sviluppo sociale e di una crescita ispirata dal sentimento civico della reciprocità e della corresponsabilità.
Per comprendere un cieco, vale molto di più osservarlo mentre cammina, con il suo bastone bianco, tra le insidie e le difficoltà del territorio civico-urbano, che ascoltare una lezione magistrale sull’incidenza della disabilità visiva sullo sviluppo del bambino.
Analogamente, per comprendere un sordo vale molto di più ricevere da lui il racconto della sua storia personale e le descrizioni più significative del suo modo di vivere le circostanze della realtà quotidiana.
Queste considerazioni ci consentono di capire come, nel caso dei disabili sensoriali, un servizio di facilitazione debba partire, per dimostrarsi adeguato, da una conoscenza qualificata della condizione personale del soggetto disabile.
E’ soprattutto importante conoscere le sue modalità di compensazione del limite sensoriale e le sue capacità di integrare esperienze, pensieri e comunicazione.
Bisogna dire che in tal senso le facilitazioni standardizzate risultano scarsamente efficaci e molto inique, considerando la grande eterogeneità di condizione nella quale vengono a trovarsi i soggetti disabili sensoriali.
Non si tratta soltanto di considerare con attenzione il profilo dinamico-funzionale di ciascuno studente, ma di praticare con lui, in misura significativa, una relazione interpersonale dalla quale possano emergere con chiarezza le sue difficoltà e le sue esigenze.
Anche i sussidi e gli ausili per facilitare lo studio dei testi non possono essere costruiti e forniti efficacemente secondo una logica “standard”, caratteristica dei servizi di base.
In particolar modo, nel caso dei soggetti non udenti, l’efficacia delle mediazioni didattiche presenta una variabilità così estesa da richiedere il supporto qualificato e tempestivo di un vero e proprio laboratorio didattico.
In altre parole possiamo chiederci se il mondo accademico abbia deciso di conoscere e di adeguarsi alla condizione degli studenti disabili sensoriali secondo astratti e semplificati criteri di categoria, oppure voglia davvero conoscere simili studenti nella realtà singolare dei loro processi di apprendimento e di integrazione sociale.
Il linguaggio della diversità ed il confronto reale con i limiti del vivere possono affermarsi e crescere soltanto in una logica della coesistenza, al di qua di risposte e soluzioni automatiche, che, per quanto ben concertate, ci proporrebbero ancora una volta un civile tentativo di evitamento del confronto.
Il disagio del confronto interpersonale può essere superato soltanto da chi accetti di viverlo, generando gradualmente i presupposti di una buona relazione.
E’ vero che viviamo in una società analgesica, nella quale il dolore viene percepito esclusivamente nella sua spiacevolezza e nella sua inutilità.
E’ anche vero che troppe volte il dolore ci è stato presentato con la superficialità mistico-salvifica di coloro che ne parlano così tanto da non essere credibili.
Ciò nonostante potremmo forse pensare che talvolta il dolore di un confronto rappresenta l’unica via per procedere oltre verso nuove e interessanti possibilità.
Ritengo che le risorse e le potenzialità presenti nella condizione umana dei soggetti non udenti siano state esplorate e conosciute in una misura decisamente scarsa.
D’altra parte ritengo che segni di risorse e potenzialità potranno essere conosciute meglio in contesti psicosociali e culturali, dove il confronto con i limiti personali divenga l’espressione di un autentico tentativo di costruire nuove forme di libertà e di corresponsabilità.
A questo proposito mi sento di affermare che il mondo accademico potrebbe finalmente riuscire a coniugare la ricerca scientifica sui disabili sensoriali e la loro integrazione sociale, in quanto studenti e studiosi.
Logicamente questo compito non poteva essere svolto dalle istituzioni speciali e nemmeno dalle associazioni dei disabili e dei genitori dei soggetti disabili.
Naturalmente però queste realtà istituzionali potranno aiutare il mondo accademico in questo difficile compito, mediante un’ordinata collaborazione nel rispetto delle specifiche competenze e finalità di ciascuna istituzione.
L’integrazione sociale, quando viene mossa dal desiderio di conoscere e dal piacere di capire, diviene una preziosa occasione per vivere meglio insieme. Quando viceversa viene mossa da una superficiale volontà di essere buoni e civili, può divenire, nelle migliore delle ipotesi, una moderna ripresentazione della beneficenza.
2. Tre aspetti rilevanti che consentono di figurare una comune prospettiva di intervento sociale per i soggetti non vedenti e non utenti
Volendo prescindere da esperienze del passato remoto, durante le quali i soggetti non vedenti e non udenti hanno vissuto insieme, “custoditi” confusamente all’interno di istituzioni segreganti e diseducative, queste due condizioni di limite sensoriale sono state raramente coniugate.
Viceversa si tratta di condizioni che offrono importanti e significativi aspetti di convergenza, soprattutto se considerate in una prospettiva di intervento sociale.
A questo proposito vogliamo qui evidenziare tre aspetti che a nostro avviso meriterebbero maggiore attenzione ed un esame ben più approfondito:
a) In entrambe le condizioni la risposta del contesto socio-familiare si dimostra decisiva ai fini di uno sviluppo adeguato ed armonico del soggetto disabile. Ciònondimeno la famiglia viene lasciata, quasi regolarmente, da sola di fronte ai propri atteggiamenti incongruenti ed ai propri comportamenti disfunzionali.
Questa potrebbe apparire una contraddizione incomprensibile se non considerassimo la naturalezza con la quale questa nostra società vive il destino dei soggetti disabili che oltre alla disabilità dovrebbero subire la non comprensione delle loro esigenze, molto spesso a partire dalle persone più vicine, più care e più significative.
b) In entrambe le condizioni il piacere e la capacità di conoscere viene disgiunto e disarticolato dal piacere e dalla capacità di comunicare.
In particolar modo l’esperienza della comunicazione viene enfatizzata, trascurando le esperienze di apprendimento implicite nel rapporto persona-ambiente.
Per altro si tratta di un errore che viene intensificato da una scuola dove le tecnologie educative trascurano la qualificazione dell’esperienza quotidiana ed il rapporto della persona con il proprio sé.
c) In entrambe le condizioni possiamo auspicarci un processo di potenziamento compensativo, sempre che non siano presenti limitazioni delle possibilità simboliche e relazionali.
Con il termine “potenziamento compensativo” intendiamo un potenziamento di risorse umane fondamentali, capaci di controbilanciare la valenza depressiva della limitazione sensoriale. In particolar modo ci riferiamo al piacere di osservare e di esplorare, al gusto di ricordare e di immaginare, al desiderio di rendersi utili ed amabili.
Evidentemente si tratta di risorse che poggiano su abilità specifiche, ma che non possono maturare dentro una logica riduttiva delle abilità.
Questi tre aspetti, benché importanti e significativi, non ci consentono davvero di accomunare in alcun modo queste due diverse condizioni sensoriali. Naturalmente non è questa la sede per approfondire le diversità presenti in queste due condizioni, né le diverse prospettive psico-pedagogiche, metodologico-didattiche e terapeutico riabilitative.
Vogliamo semplicemente limitarci a svolgere una breve considerazione per indicare la diversità del vissuto, derivante in qualche modo dalla diversità del limite sensoriale.
La cecità implica la condizione di buio interiore, la perdita di un oggetto interno luminoso, che può essere facilmente vissuta come presenza minacciosa, come perdita dell’autostima e della fiducia nelle risorse personali.
La sordità implica la condizione di silenzio esteriore e la squalificazione di un ambiente che non dice nulla, che ci esclude poiché non entra in contatto con la nostra interiorità.
Per questa ragione la condizione di sordità implica prevalentemente un vissuto di esclusione da un ambiente nel quale, forse, non vale la pena di essere inclusi.
Com’è facile constatare, si tratta di vissuti molto diversi che, pur nascendo entrambi da un’esperienza di limite sensoriale, tendono a concretizzarsi attraverso risposte divergenti.
Nei ciechi è più forte il desiderio di essere inclusi, la volontà di partecipare e di agire insieme con gli altri.
Nei sordi è molto più forte il sentimento dell’indipendenza, il desiderio di autonomia, la volontà di vivere tra sordi il piacere di esistere e di convivere.