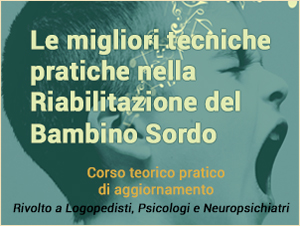Sommario:
- L’esperienza di apprendimento scolastico degli alunni sordi tra classi speciali e ordinarie
- Linguaggi comunicazione ed esperienza
- Gli studenti disabili sensoriali nelle università: verso un percorso di apprendimento personalizzato
b. Linguaggi comunicazione ed esperienza
Possiamo considerare la realtà della comunicazione distinguendone tre livelli e seguendo un itinerario di complessità crescente, ove il secondo livello includa il primo e conseguentemente il terzo includa i primi due.
Primo livello: condivisione di un campo percettivo e comunicazione intersoggettiva dei comportamenti.
Si tratta di situazioni nelle quali ci limitiamo a percepire la presenza dell’altro o comunque, a tener conto che l’altro ci potrebbe osservare, interpretando il nostro comportamento.
In questi casi, peraltro i più frequenti, la comunicazione consiste nell’intreccio circolare delle mie interpretazioni sui comportamenti dell’altro con le interpretazioni che l’altro attribuisce ai miei comportamenti.
Secondo livello: condivisione di pratiche più o meno concertate, allo scopo di raggiungere un obiettivo in qualche misura comune.
Evidentemente si tratta di situazioni più complesse e meno frequenti, durante le quali il comportamento dell’altro viene percepito e interpretato in ragione dell’obiettivo da perseguire, ma anche secondo un giudizio privato più generale, congruente con le problematiche del primo livello.
Terzo livello: condivisione dei vissuti di coscienza e dei significati personali che accompagnano l’azione degli interlocutori.
E’ questa la sede della comunicazione interpersonale, la quale consente la socializzazione delle esperienze (ad esempio: “io e te parliamo di me”, “io e te parliamo di te”).
Naturalmente si tratta di situazioni poco frequenti, poiché si realizzano sulla base di una molteplicità di presupposti personali e socioculturali.
E’ più frequente una particolare forma di socializzazione delle esperienze, del tipo “io e te parliamo di lui”, con la quale si organizza più che altro il comune sentire del giudizio sociale.
E’ anche frequente una socializzazione dell’esperienza che prescinde da pratiche comuni di vita quotidiana e che pertanto poggia quasi esclusivamente su basi verbali.
L’intimità verbalistica è soltanto una rappresentazione paradossale del terzo livello, poiché in effetti rappresenta una situazione più vicina alle caratteristiche del primo livello, nonostante la maggiore complessità verbale.
A questo punto, se consideriamo i diversi linguaggi in relazione a questa distinzione di livelli circa la realtà della comunicazione, possiamo affermare quanto segue:
A) Il primo livello esige più che altro la dimensione analogica del linguaggio, vale a dire un linguaggio centrato sulla somiglianza e sull’immediatezza, orientato prevalentemente dall’urgenza espressiva delle emozioni e dall’esigenza di un effetto pratico.
B) Il secondo livello richiede inoltre l’uso di linguaggi tipicamente processuali validi soprattutto nell’indicare sequenze di operazioni ben precisate nello spazio e nel tempo.
In tal senso risultano maggiormente adeguati tutti i linguaggi a forte componente numerica, poiché si emancipano dalle ambivalenze e dalle incongruità, così frequenti e diffuse nell’espressione analogica.
C) Il terzo livello richiede un ulteriore grado di complessità linguistica, poiché ha bisogno di un linguaggio provvisto di notevoli risorse semantiche, per organizzare e coordinare le somiglianze e le diversità.
Nelle situazioni di terzo livello occorre inoltre coniugare e talvolta conciliare gli aspetti pragmatici della comunicazione con gli aspetti sintattici e semantici, raggiungendo il più elevato grado di complessità.
A questo proposito giova sottolineare che un simile grado di complessità linguistica rappresenta comunque la base di una alfabetizzazione culturale per vivere agevolmente nell’attuale modello sociale di civiltà.
Ciononostante oggi è forte la tendenza a praticare una semplificazione riduttiva del linguaggio, considerando quasi esclusivamente i primi due livelli della comunicazione, quasi che il terzo sia una complicazione del vivere o peggio, qualcosa di estraneo.
Nel caso particolare dei bambini sordi, una simile tendenza risulta ancora più forte e determinata.
Sia accetta con eccessiva naturalezza che la complessità lessicale costituisca per il bambino sordo un costo troppo faticoso, rispetto al beneficio che gliene potrebbe derivare.
D’altra parte la storia dell’educazione dei sordi non ha mai posto l’amore per le parole come un obiettivo strategico di prima grandezza per la qualificazione dell’esperienza e per lo sviluppo dei bambini non udenti.
Riteniamo che le difficoltà di fonazione dei bambini non udenti possano risultare disgiunte dal piacere della nominazione e dal gusto dell’espressione verbale.
Un obiettivo così ambizioso presuppone almeno due mutamenti radicali dell’attuale orientamento culturale.
In primo luogo è necessaria una riaffermazione ed una ridefinizione del valore presente nella parola scritta, quale risorsa essenziale per il potenziamento della vita e della conoscenza umana.
In secondo luogo occorre la volontà da parte dei sordi di migliorare la propria presenza sociale mediante una voce più distinta ed autonoma, tale da incidere con maggiore efficacia sui principali pregiudizi che offendono la loro immagine, riducendo le loro prospettive umane e sociali.