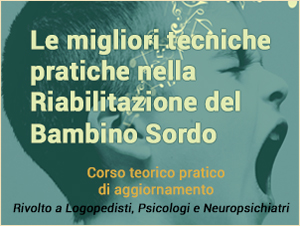Sommario:
- L’esperienza di apprendimento scolastico degli alunni sordi tra classi speciali e ordinarie
- Linguaggi comunicazione ed esperienza
- Gli studenti disabili sensoriali nelle università: verso un percorso di apprendimento personalizzato
a. L’esperienza di apprendimento scolastico degli alunni sordi tra classi speciali e ordinarie
Un esame critico dell’esperienza e del comportamento di un alunno sordo continua a risentire spesso della tendenza dicotomica con la quale la scuola speciale e la scuola ordinaria vengono poste a confronto.
Occorre subito aggiungere, in secondo luogo, che permane anche una significativa resistenza a considerare la condizione umana e sociale di un alunno sordo nel singolare insieme delle sue variabili personali, vale a dire, l’entità del danno sensoriale, il momento di insorgenza della minorazione e le caratteristiche individuali del rapporto persona-ambiente.
Bisogna dire in terzo luogo che l’osservazione delle singole situazioni viene più che altro condotta mediante classificazioni schematiche secondo criteri convenzionali, che offrono uno spazio esiguo e comunque insufficiente ad una ricerca più approfondita e ad una osservazione clinica partecipe.
Questi tre aspetti trovano una loro nitida connessione nel concetto di confronto con la diversità che rappresenta, a mio modo di vedere, la base “naturale” di un ragionamento che voglia impostare il problema in una forma dinamica e dialettica.
A questo proposito ci sembra giunto il momento di affermare con la necessaria efficacia che un equilibrato e complessivo confronto con la diversità può attuarsi compiutamente soltanto nel caso in cui l’alunno disabile possa vivere la sua esperienza scolastica con alunni normodotati ed anche con alunni che presentino la sua stessa limitazione funzionale.
Con gli altri sordi, l’alunno potrà consolidare la propria condizione personale, qualificando le proprie potenzialità di apprendimento in un contesto di familiarità, caratterizzato da criteri di insegnamento già sperimentati e rispettosi dell’elevata specificità di una condizione sensoriale così complessa e difficile da focalizzare.
Nel gruppo dei coetanei normodotati l’alunno sordo potrà concepire la propria diversità personale, valutare e modellare meglio la propria identità di alunno e di futuro cittadino, imparando le più opportune strategie psicosociali di inserimento e di integrazione.
Occorre soprattutto comprendere che il confronto con una diversità limitante può svilupparsi positivamente soltanto se accompagnato e sorretto da una forte esperienza di somiglianza, vale a dire di rispecchiamento critico tra simili.
In particolar modo, quando la diversità presenta un elevato grado di specificità, tale da non consentire una comprensione intuitiva e immediata dei problemi dell’altro, il gruppo sociale tende ad assumere un comportamento analgesico e mimetizzante.
In simili circostanze il confronto con la diversità perde quasi interamente il suo valore di apprendimento e di conoscenza, assumendo la connotazione della spiacevolezza e della penosità. Si preferisce minimizzare o addirittura eludere i problemi, concentrandosi su qualche aspetto tecnico-parcellare, nel quale vengano posti con enfasi i desideri e i sogni di cancellazione del problema.
D’altra parte occorre anche comprendere che l’esperienza di somiglianza tra diversi dello stesso tipo, tende ad organizzare, con il passare del tempo, luoghi rassicuranti ove si possa coltivare, più o meno consapevolmente, una sorta di mito dell’indipendenza che certamente non facilita il confronto con il limite e con la diversità.
Viviamo in una società che intende superare l’esperienza del dolore attraverso la fuga dal dolore, complicando ulteriormente la struttura della nostra esistenza.
Cerchiamo pertanto di combattere questa pericolosa e nociva illusione, ascoltando con attenzione i segnali provenienti dal dolore per superarli mediante risposte più qualificate e costruttive, che non inseguano le frenesie di semplificazione mirando diritto alla soluzione dei problemi, intesi nella loro dimensione complessivamente umana.
***
Riteniamo che in conclusione possa giovare una definizione di ciò che abbiamo chiamato “confronto con la diversità”, poiché una simile espressione potrebbe indurre fraintendimenti legittimi quanto nocivi.
Il confronto con la diversità scaturisce, a nostro avviso, dalla coscienza del limite e della specificità con cui possiamo rispondere al limite, compensando interamente o parzialmente la disabilità che esso comporta.
Naturalmente la consapevolezza del limite non può maturare in misura sufficiente in un contesto sociale ove non sia possibile un confronto quotidiano con i coetanei normodotati.
D’altra parte la consapevolezza di una risposta compensativa qualificata e della dignità del proprio modo specifico di percepire non possono che nascere da un confronto altrettanto quotidiano con altri coetanei caratterizzati dalla stessa disabilità.
Più generalmente potremmo dire che il confronto con la diversità è il confronto con i propri limiti, intesi come perimetro figurativo della propria identità personale e delle proprie possibilità.
In questo significato più ampio il confronto con la diversità appartiene a ciascuno di noi, a prescindere dalla presenza di una disabilità.
In effetti è il limite che ci rende riconoscibili e rappresenta, nello stesso tempo, l’orizzonte della nostra esistenza, un orizzonte da oltrepassare e da estendere di volta in volta.
E’ nel dinamismo di una simile identità che diveniamo degni di conoscere, di conoscerci e di essere conosciuti.
La scuola potrebbe e dovrebbe aiutarci in questo cammino, facilitando i nostri tentativi di orientamento e di impegno.
Viceversa troppo spesso la scuola tende a chiudersi entro sterili convenzionalismi che non offrono adeguato respiro alla complessità polivalente dei processi di apprendimento e di sviluppo.
E’ il piacere di conoscere che rende la scuola capace di accogliere le diversità individuali. Senza questo piacere la diversità ci offre soltanto il suo volto perturbante e la sua penosa vertigine.
Non ci resta pertanto che affermare soprattutto l’interesse presente nella nostra condizione di disabili sensoriali e far capire che vale la pena conoscerci, poiché conoscere noi significa anche conoscere molto meglio la specie umana e le possibilità nascoste, talvolta oppresse, dal nostro vivere sociale.