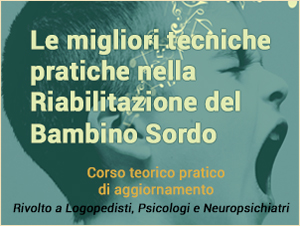Non ricordo di aver mai usato con entusiasmo matite colorate o altri strumenti per disegnare qualcosa sopra un foglio. Ciononostante mia madre mi ha raccontato più volte che da piccolo, all’età di tre o quattro anni, chiedevo spesso l’occorrente per disegnare, collocandomi in ginocchio sulla sedia di fronte al bordo del tavolo della cucina.
Forse, in questo mio desiderio, c’era il tentativo di imitare mio fratello, molto bravo e capace dal disegno dal vero e molto lodato per questa sua virtù.
Per quanto prezioso, il mio residuo visivo era ben poca cosa e mi costringeva ad avvicinare di molto gli occhi al foglio, quasi al punto di sfiorarlo con la punta del naso.
Mentre disegnavo in quella strana posizione, si avvicinava mia madre e con gesti tanto affettuosi quanto preoccupati cercava di allontanare la mia testa dal foglio, mostrandomi quale fosse la giusta distanza da assumere.
Presumibilmente a quel punto il mio dilemma consisteva in una scelta comunque disastrosa: accontentare mia madre, continuando a disegnare “alla cieca”, con risultati che avrebbero ugualmente messo in evidenza il mio limite sensoriale oppure mantenere gli occhi vicini al foglio, affermando vistosamente la mia diversità e producendo i già conosciuti effetti perturbanti sui miei familiari.
Nella impossibilità di decidere fra due “non soluzioni”, mi andavo a sdraiare a pancia sotto sopra una vecchia cassapanca, vicino alla finestra, e continuavo a disegnare in una posizione che rendeva quasi naturale la vicinanza della mia faccia al foglio.
Questa condizione di apparente normalità placava l’inquietudine di mia madre e soddisfaceva, allo stesso tempo, la mia volontà di disegnare.
Qualcuno potrebbe obiettare, davvero ingenuamente, che anche la scelta della cassa panca non rappresentava una reale soluzione del problema, ma semplicemente una sua compassionevole mimetizzazione.
Potrei rispondere a questo immaginario interlocutore che la soluzione del problema, per un bambino di tre o quattro anni, coincide quasi sempre con l’armonia del suo contesto familiare.
In nome dell’armonia un bambino è disposto a sacrificare una buona parte di se stesso, poiché nell’armonia egli trova il necessario conforto alla grande paura di restare solo.
Soltanto più tardi egli potrà comprendere l’importanza di rispettare sé stesso e sentire nel dialogo, nella contraddizione, nel disaccordo l’opportunità e la prospettiva di un’intesa più ampia e più profonda, predisposta a concepire il valore e il significato delle differenze individuali.