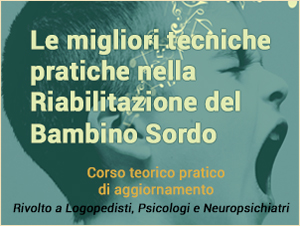Sommario:
- Un intervento meno generico
- Il bambino pluridisabile visivo tra sociocompatibilità e piacere di esistere
- La dimensione del contesto nell’educazione dei soggetti disabili visivi con minorazioni aggiuntive
- Alunni non vedenti e ipovedenti con disabilità aggiuntive: l’intervento socioriabilitativo nel contesto del progetto educativo personalizzato.
- L’identità del bambino non vedente pluriminorato nel contesto della riabilitazione
- Significato e valore della presenza sociale dei soggetti non vedenti pluriminorati
b. Il bambino pluridisabile visivo tra sociocompatibilità e piacere di esistere
Abitualmente utilizziamo la parola «diversità» senza riflettere a fondo sul suo significato.
Ciò accade soprattutto quando desideriamo enfatizzare il valore della diversità nelle sue implicazioni sociali, civili e culturali.
In particolar modo l’aspetto su cui non riflettiamo abbastanza è il diverso modo con il quale ciascuno di noi vive una singola diversità nella sua qualità caratteristica.
In questo senso la diversità è un concetto molto astratto che si riferisce ad una molteplicità davvero immensa di significati concreti, molto “diversi” tra loro.
In ogni caso bisogna dire che alcune diversità comprendono un insieme di fenomeni sufficientemente omogenei ed altre invece comprendono insiemi decisamente eterogenei.
Per quanto riguarda i soggetti disabili, il nostro desiderio di semplificazione ci induce a prediligere le categorie più omogenee, rispetto alle quali torna più facile concepire e praticare strategie di insegnamento.
A questo proposito la categoria degli alunni pluridisabili non vedenti o ipovedenti è indubbiamente uno tra gli insiemi meno omogenei e quindi meno prediletti.
Se poi ragioniamo sul nostro atteggiamento e sui nostri comportamenti in una prospettiva propriamente intrapsichica, dobbiamo subito renderci conto che ciascuna singolare diversità possiede una sua valenza perturbante in rapporto con la nostra personale realtà psichica.
In linea generale possiamo dire che ci riesce più facile concepire l’altro quando il suo modo di essere diverso non ci impedisce di rispecchiarci nella sua immagine e nella sua condotta.
Una diversità concepibile poggia infatti sopra una base emozionale di somiglianza e vive in un contesto di rispecchiamenti possibili.
Viceversa può accadere che ci troviamo in relazione con una diversità che non riusciamo a concepire, che sembra non offrirci alcuna possibilità di rispecchiamento. In questi casi la diversità ci si presenta come aliena, come eccessiva, producendo in noi penose sensazioni di impotenza, di separazione e di smarrimento.
In simili circostanze la fuga dal campo percettivo rappresenta la risposta più immediata e naturale, anche se frequentemente viene repressa dall’attaccamento affettivo e dal sentimento del dovere.
quando non possiamo fuggire dal campo di condivisione percettiva, siamo indotti a cercare comunque la via di un rispecchiamento e solitamente lo cerchiamo in un frammento dell’altro, in un suo aspetto parcellare che ci consenta di recuperare una porzione di rispecchiamento, nella quale trovare la forza per organizzare una relazione.
Per questa ragione accade spesso che i genitori (ed anche gli insegnanti) concentrano la loro attenzione sopra un aspetto estetico del bambino pluridisabile visivo, oppure sopra una sua particolare abilità che possa lasciar fantasticare una futura funzione sociale, che faccia da riferimento per sognare in qualche modo “una sua rinascita”.
Generalmente questi aspetti parcellari del bambino vengono curati con grande sollecitudine e con pratiche di comportamento così rituali da risultare molto spesso compulsive.
Naturalmente anche il bambino vive la propria identità rispecchiandosi in alcuni frammenti di sé stesso e, così facendo, organizza una struttura dell’io frammentaria e disarmonica.
Nel bambino vengono a mancare le coordinazioni complessive, poiché la sua presenza umana non viene mai considerata per intero.
A questo proposito occorre comprendere come una persona (e in particolar modo un bambino in via di sviluppo) abbia l’esigenza di essere considerato nella sua interezza e di percepire nell’ambiente il significato della propria presenza umana.
Essere costretti a riconoscere la nostra vita in un frammento estetico oppure in un comportamento funzionale non ci consente neppure di concepire e di individuare la globalità del nostro sé e della nostra realtà personale.
In tali situazioni l’esperienza ci suggerisce che non giova contestare ai genitori e agli insegnanti la parcellarità della loro attenzione nel rapporto con il bambino.
Si tratta invece di offrire loro una testimonianza concreta circa il significato da offrire alla presenza del bambino, inteso come persona partecipe e attiva nel suo contesto di appartenenza.
Questa testimonianza ci diviene possibile quando riusciamo a liberarci da una concezione preconfezionata dell’esistenza umana e a rappresentarci le forme della vita umana con un sufficiente grado di spregiudicatezza.
Al di qua dei pregiudizi un soggetto pluridisabile visivo ci offre la complessità e la ricchezza di una presenza umana, tutta da conoscere ma anche tutta da rispettare nella sua dimensione non conoscibile.
Accogliendo la dimensione del “non conoscibile” diviene possibile rispecchiarci nella sua presenza globale, poiché gli aspetti misteriosi del vivere ci accomunano e ci rendono tutti molto somiglianti.
L’attuale concezione del progresso tecnologico nutre un atteggiamento riluttante ed aggressivo nel confronto con ciò che non può essere conosciuto, poiché enfatizza il valore della sicurezza di sé e la fiducia nei propri mezzi individuali e sociali.
Evidentemente l’esistenza di un soggetto pluridisabile visivo trova spazio, respiro e significato soltanto in un contesto sociale caratterizzato da un clima di solidarietà, dove la presenza umana non venga misurata esclusivamente nei termini della produttività mercantile, ma anche secondo i criteri dell’appartenenza, della fecondità e della partecipazione.
In questo senso bisogna dire che un soggetto pluridisabile visivo può darci davvero molto, con la semplicità dei suoi desideri, con l’immediatezza del suo affetto, con la meraviglia delle sue lente ma significative conquiste funzionali.
Anche se talvolta, purtroppo, non ce ne accorgiamo, la sua presenza offre nuova autenticità alla vita del gruppo e moltiplica le opportunità di relazione interpersonale.
I bisogni del bambino pluridisabile visivo, spesso primitivi e rudimentali, contribuiscono ogni giorno a farci sentire utili e a riconquistare un significato dell’esistenza più chiaro e fondamentale.
Lo scambio che potrà avvenire tra una società tecnologica avanzata e i bambini pluriminorati non vedenti è davvero interessante in una prospettiva di cultura postmoderna.
Infatti la società, da parte sua, potrà offrire sempre di più e sempre meglio strumenti ed ambienti intelligenti, allo scopo di favorire la loro indipendenza e la loro autonomia.
Da parte loro i bambini pluridisabili potranno offrire alla società un piacere di esistere più libero dai condizionamenti provenienti dal disagio della civiltà.
Tutto questo presuppone però una prospettiva di riabilitazione, ispirata prevalentemente dalla finalità di armonizzare l’esistenza dei soggetti pluridisabili.
Il potenziamento di singoli aspetti o funzioni della loro personalità dovrà essere opportunamente bilanciato nel contesto di tale imprescindibile finalità, globale e prioritaria.
Siamo ragionevolmente convinti che da un lato occorra aiutare con ogni mezzo i bambini pluridisabili visivi a divenire più somiglianti e compatibili (accettabili) nel gruppo sociale di appartenenza.
D’altro lato riteniamo che l’accettabilità di simili bambini non possa in alcun modo assumere le caratteristiche di un’offesa repressiva del loro piacere di esistere.
Infatti in una società civile il rispetto della vita umana non dovrebbe mai risultare subordinato ad un criterio di conformità, anche nel caso in cui alcune particolari forme di vita ci procurassero intense e spiacevoli perturbazioni emozionali.
Essere perturbanti contro la nostra volontà non può davvero configurare una fattispecie di reato, né morale né civile.
Si tratta invece di cercare tutti insieme una maggiore capacità di governare le nostre personali perturbazioni, per dare corpo ad una società umana più tollerante e più intelligente.
In una simile società i soggetti pluridisabili potranno conoscere molto meglio il gusto del vivere e potranno forse aiutarci a condurre un’esistenza più libera dall’ansia delle prestazioni e dall’impietosa pratica dell’obiettivo.